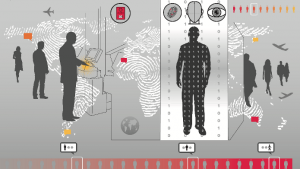Di seguito vi proponiamo la
traduzione di un articolo scritto da Dilar Dirik, compagna curda e
dottoranda presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Cambridge.
Pensiamo che la lettura del testo apra, nell’ottica di una crescita,
delle riflessioni sulla solidarietà per rafforzare un fronte comune di
lotte senza frontiere.
Le dinamiche raccontate possiamo riscontrarle nel posizionamento,
nei discorsi e nell’agire politico di numerosi gruppi internazionalisti
occidentali ma, nella profonda critica proposta, possiamo riconoscere
limiti e problemi del nostro stesso agire.
Buona lettura.
Sfidare il privilegio: sulla solidarietà e l’autoriflessione
La solidarietà non è carità unilaterale
praticata da attivisti privilegiati, ma un processo multidimensionale
che contribuisce all’emancipazione di tutte le persone coinvolte.
Un uomo tedesco non è colpito dal progetto di democrazia di base in
Rojava perché ha visto qualcosa di simile decenni fa in America Latina.
Una donna francese rimprovera le donne kurde di una mancanza di
preparazione durante la sua visita perché non sono organizzate come le
donne afghane che lei ha conosciuto negli anni ’70. Una persona riesce a
passare come un membro rivoluzionario del Rojava dopo un viaggio di una
settimana e senza avere accesso a media e letteratura in qualche lingua
mediorientale, ma la sua opinione è comunque considerata più legittima e
autentica di quella delle persone che lottano.
Cos’hanno in comune le esperienze di queste persone?
Esse mostrano un interesse e una preoccupazione genuine, e i loro sforzi
meritano il dovuto credito. Ma c’è qualcosa di più: l’elemento che sta
alla base di un sistema che permette alle persone di completare la loro
lista del turismo rivoluzionario – negli scorsi decenni in particolare
in Palestina e Chiapas, adesso in Rojava. Questo elemento è un qualcosa
che i rivoluzionari devono problematizzare attivamente: il privilegio.
Per fare chiarezza dal principio: come qualcuno che scrive quasi
prettamente per un pubblico internazionale, che facilita la
comunicazione e incoraggia le delegazioni in Kurdistan, io appartengo a
quelle persone che fondamentalmente danno valore a questo tipo di
scambio e lavoro. Ma le persone che dichiarano solidarietà e che sono in
una posizione privilegiata, che permette loro di viaggiare ed essere
ascoltate, hanno l’obbligo morale di usare al meglio questo privilegio.
L’intenzione di questo articolo è contribuire al dibattito sui problemi
che emergono quando vengono stabilite relazioni gerarchiche in nome
della solidarietà.
Sfidare i privilegi
In un mondo di stati nazione capitalisti e patriarcali, considerare se
stessi come cittadini del mondo e opporsi alle idee di nazioni e stati è
un atto di ribellione. Tuttavia, pensarsi come rivoluzionari
internazionalisti non cancella condizioni inique e privilegi. È
necessario andare oltre.
Prima di tutto, c’è una serie di privilegi materiali e risorse di cui
una persona beneficia: passaporti di stati che ti aiutano a viaggiare
quasi ovunque; parlare lingue internazionali e possedere un vocabolario
teorico che ti facilita nell’articolare e dar forma a un discorso;
padroneggiare strumenti intellettuali grazie all’educazione di base,
così come avere tempo, sicurezza e soldi a sufficienza per procurarsi la
maggior parte di queste cose. L’assenza di guerra, morte, distruzione,
evacuazione, carestia e traumi ti permette di condurre ricerche in
sicurezza e comodamente, prendere decisioni e pianificare a lungo
termine, vivere secondo principi senza troppi ostacoli.
Il solo fatto di avere la possibilità di sedersi a prendere un caffè,
leggere su un argomento da fonti scritte nelle storiografia, teoria,
lingue e epistemologia occidentale-centriche è un privilegio che la
maggior parte delle persone non bianche e i lavoratori non hanno. E
anche se ce l’avessero, spesso a queste persone manca un ambiente
politico in cui poter discutere le loro visioni.
Il solo fatto che io stia scrivendo questo articolo altresì indica il
privilegio di qualcuno che proviene da un gruppo oppresso e
marginalizzato ma che, rispetto alla sua gente, ha accesso ad alcune
risorse e vantaggi. Ovunque esista il privilegio, esiste la relativa
responsabilità di sfidare il privilegio. Il problema non è tanto la mera
esistenza del privilegio, quanto la creazione di relazioni gerarchiche e
-involontariamente- l’atteggiamento paternalistico e di appropriazione
nel lavoro di solidarietà, che interrompono la comprensione reciproca e
l’avanzamento.
Alcuni hanno espresso il loro stupore per l’ignoranza delle persone
locali riguardo lotte simili alle loro in un altro capo del mondo, e
hanno tentato di rendere più tenui i discorsi delle vittime perché la
loro realtà quotidiana era troppo dura per essere ascoltata dalle
delicate orecchie occidentali. Altri hanno rifiutato ogni forma di
auto-riflessione quando sono stati accusati di aver distorto il discorso
sulla lotta delle persone attraverso narrative imposte in un modo
alienante per le persone in questione, insinuando invece che le persone
oppresse dovrebbero essere grate di ricevere una qualsiasi attenzione.
Il problema sta nella facilità con cui una persona privilegiata si senta
in diritto di poter scrivere interi libri su un’intera regione senza
averla mai visitata. È la bianchitudine maschile di intere sessioni di
conferenze “radicali” sulle lotte portate avanti da persone di colore. È
la famosa espressione di simpatia della persona bianca per una causa
che dà a chi la sposa la possibilità di essere alla moda. È la velocità
con cui le motivazioni riguardanti lotte per la vita e la morte vengono
abbandonate come una patata bollente non appena queste stesse lotte
diventano più complicate di quanto previsto.
Com’è conveniente per un rivoluzionario aver la possibilità di
scrollarsi di dosso responsabilità e identità senza altre complicazioni!
Molte persone di sinistra provenienti da nazioni privilegiate, mentre
sottolineano spesso in modo militante di non rappresentare alcuno stato,
esercito, governo o cultura, possono però facilmente analizzare milioni
di persone come un gigantesco blocco monolitico. Cancellando i propri
contesti, spesso concedono per se stessi un agire individualistico e
complesso, sentendosi in questo modo piuttosto generosi e caritatevoli
quando discutono tra loro su chi “meriti” supporto, mentre l’Altro sfuma
in astratte identità.
I veri compagni si vedono nella notte più fredda
I modi in cui oggi la solidarietà è progettata per lo sguardo
occidentale ha un altro effetto devastante sui movimenti: la
competizione tra le persone in lotta per l’attenzione e le risorse.
Invece di costruire legami tra loro, le persone che lottano sono
costrette a combattere prima per ricevere le attenzioni della sinistra
occidentale, cosa che mette le comunità l’una contro l’altra ed è
distruttiva per l’internazionalismo. Come fa notare Umar Lateef Misgar,
un attivista del Kashmir: è come un’evoluta forma del divide et impera
di coloniale memoria.
Sopratutto il maschio bianco istruito ha il lusso e privilegio di poter
visitare ogni luogo in cui è in corso una rivoluzione, di appropriarsene
come preferisce, e poi di provvedere a criticarlo senza condizioni e
senza sentire mai la necessità di guardare in casa propria. Spesso con
un senso di possesso senza responsabilità, può avvicinarsi a livello
internazionale, allontanarsi a livello locale e viceversa. La sua
identità trascende l’etnicità, la nazionalità, il genere, la classe
sociale, la sessualità, la fisicità, l’ideologia, perché è
l’incarnazione dell’impostazione predefinita, lo status quo – egli a
malapena vive o conosce il significato della devianza. Non sa che la
maggior parte delle lotte inizia da una richiesta di riconoscimento, di
un posto nella storia, perché è lui quello che la scrive. Così spesso
non riesce ad afferrare le motivazioni rivoluzionarie oltre la teoria. È
questo purismo ideologico che gli permette così facilmente di
rinunciare alla solidarietà con le lotte, ed è anche forse la più grande
espressione del suo privilegio: può permettersi di essere
dogmaticamente, ideologicamente puro; può predicare consistenza teorica,
perché il suo interesse per una lotta non è una questione di
sopravvivenza ma mera attrazione. Non è obbligato a sporcarsi le mani.
Può allontanare il suo sguardo dalle persone che combattono per la vita,
perché non è lui quello che deve equilibrare gli ideali contro tutti i
tipi di condizioni geopolitiche e socio-economiche, conflitti religiosi
ed etnici, violenza, guerra, tradizione, traumi e povertà.
Ed è per questi motivi che le persone possono abbandonare una causa
tanto velocemente così come velocemente l’hanno abbracciata, perché la
risoluzione di errori, limiti e ostacoli che le rivoluzioni affrontano
richiederebbe uno sforzo che loro non vogliono fare – discussioni
teoriche o conferenze con caffè e torta sono spazi molto più comodi per
le invettive radicali rispetto a quell’inferno chiamato Mesopotamia.
Quando le persone non ricevono dalle lotte reali le gratificazioni
immediate, richieste dalla mentalità capitalista che hanno
interiorizzato, possono lasciar cadere in fretta momenti storici della
rivoluzione. L’opzione di abbandonare, di ritirarsi da una causa non
appena il fascino romantico iniziale svanisce e ne emerge la crudezza,
semplicemente non è disponibile per le persone che lottano per la vita o
la morte. I veri compagni, dopotutto, non si vedono col tepore del sole
ma nella notte più fredda.
Lotte legittime messe alla prova
Qualche tempo fa, appartenenti all’estrema sinistra hanno scritto
articoli botta e risposta sul Rojava senza avere alcun contatto con la
realtà sul campo, attraverso supposizioni e argomenti che erano dei
non-problemi per le persone coinvolte. Presto ciò si è trasformato in
una discussione profondamente orientalista interna alla sinistra
occidentale, dove un uomo bianco si rivolge a un altro,
senza che nessuno sia stato nella regione o abbia letto qualcosa di
diverso da opinioni di altri uomini bianchi trovate online – con il
Rojava utile semplicemente come metafora del Terzo Mondo su cui poter
proiettare tutte le ideologie e ipotesi.
Naturalmente le analisi e la prospettiva critica internazionali sono
fondamentali per i processi rivoluzionari, ma i dogmatismi, gli
sciovinismi e l’arroganza sono al servizio di un obiettivo opposto.
Tralasciando il fatto che queste persone erano molto lontane
dall’organizzare rivoluzioni nei propri contesti, comunque si sentivano
nella posizione di giudicare autorevolmente cosa fa o no una rivoluzione
offrendo inoltre consigli e direttive alle persone che formano comuni
autonome di donne mentre combattono l’ISIS.
In un certo senso, tale falsa rappresentazione e distorsione sono
necessarie per legittimare immagini orientaliste e interventi
colonialisti. Come ha elaborato Sitharthan Sriharan, un attivista Tamil,
“i privilegiati di sinistra spesso, con le loro azioni, aiutano a
produrre e a riprodurre le stesse forze di cui si dichiarano nemici.”
È interessante vedere come lotte legittimate nel corso di decenni dalle
migliaia di persone che ne hanno preso parte, debbano esser messe alla
prova del nove dalla sinistra ed essere giudicate dall’Occidente prima
di essere ritenute importanti. Simili presupposti fanno male ai
movimenti di liberazione, nella misura in cui si rifiutano di darne
un’attenzione appropriata e un’accurata rappresentazione; possono
realmente causare significativi danni politici, sociali, economici ed
emotivi, perpetuare la disinformazione e delegittimare intere lotte
attraverso un discorso dominato da gruppi esterni.
Queste attitudini fondamentalmente affondano le proprie radici nelle
ideologie eurocentriche che hanno stabilito il loro imperialismo
culturale tramite colonialismo, dogmi modernisti e capitalismo. La
violenza simbolica che ritrae la storia occidentale come moderna e
universale oggi si manifesta nelle forme di orientalismo nelle scienze
sociali e influenza il modo in cui ampie sezioni della sinistra
occidentale intendono la solidarietà.
Accorgersi del proprio privilegio
L’assunto per cui la solidarietà sia unidirezionale, qualcosa che uno dà
e un altro prende, è fallace dal principio. La solidarietà oggi,
specialmente nell’era dell’informazione e della tecnologia digitale, è
espressa in un modo che articola una relazione dicotomica tra un
soggetto attivo e pensante che “procura” solidarietà a una causa e un
gruppo che può solo reagire come oggetto passivo senza il diritto di
offrire un riscontro critico rispetto a quale tipo di solidarietà sia
richiesto.
I distributori di solidarietà possono apparire da ovunque, cancellare i
propri contesti di provenienza e autonominarsi dominatori del discorso. A
loro è garantita una visione a volo d’uccello, che permette prospettive
analitiche distanziate e autorità, dovuta a una supposta posizione
“imparziale”. Questo crea immediatamente una gerarchia e l’aspettativa
che il gruppo che riceve solidarietà debba dimostrare gratitudine e
deferenza a chi la offre, ponendosi così alla mercé della persona che
garantisce il supporto. Ciò spesso segna la fine della solidarietà e
l’inizio della carità.
A ogni modo, i gruppi oppressi non hanno l’obbligo o la responsabilità
di dar niente in cambio. Come fa notare la mia cara amica Hawzhin Azeez
da Kobane: “Non dobbiamo ringraziare le persone privilegiate per essersi
accorte dei loro privilegi e fare la cosa giusta. Non dobbiamo
aspettarci nulla di meno da loro perché questo è il presupposto
implicito che sta alla base della solidarietà.”
Le persone che si dichiarano alleate devono essere disposte a caricarsi
il peso di un duro lavoro. Dovrebbero ricordare a se stesse i propri
privilegi, sfidarli costantemente e annullarli per trasformarsi in
strumenti capaci di amplificare le voci e i principi dei movimenti con
cui affermano di essere solidali – invece di diventare la voce o
l’incarnazione della lotta altrui. Non dovrebbero aspettarsi gratitudine
e medaglie al valore per comportarsi eticamente, almeno non da persone
marginalizzate che sono solo felici che qualcuno stia parlando della
loro battaglia per l’esistenza.
Dalla carità alla solidarietà, dall’insegnare all’imparare
Il movimento di liberazione kurdo utilizza “critica e auto-critica” come
meccanismi produttivi ed etici per migliore se stessi, gli altri e il
gruppo. Criticare un altro significa anche essere in grado di criticare
se stessi. La critica non è intesa per danneggiare gli altri, ma è
fondamentalmente basata su empatia, onestà e risoluzione dei problemi.
Il lavoro solidale non immunizza di certo nessuno dalla critica. Al
contrario, la richiede. Per essere davvero etica, la solidarietà si basa
essenzialmente su questa. Ma, a oggi, il lavoro solidale della sinistra
eurocentrica è stato largamente privo di questo tipo di critica,
accentuando gli ostacoli interni alla sinistra occidentale e la sua
incapacità di organizzare o persino discutere le premesse di base.
Fondamentalmente, un vero rivoluzionario è una persona che inizia un processo rivoluzionario interiore partendo da se stesso.
La solidarietà non è un progetto di carità, ma un processo orizzontale,
multidimensionale, educativo e pluridirezionale che contribuisce
all’emancipazione di tutte le persone coinvolte. Solidarietà significa
essere allo stesso livello dell’altro, stare fianco a fianco. Vuol dire
condividere competenze, esperienze, conoscenze e idee senza perpetuare
relazioni basate sul potere. La differenza tra carità e solidarietà è
che la prima ti definisce “stimolante” e vuole farti la lezione, mentre
la seconda ti chiama “compagno”, e vuole imparare da te qualcosa. Per
affrontare questi problemi, non è abbastanza l’autoriflessione per ogni
individuo. In realtà abbiamo bisogno di un nuovo paradigma di
solidarietà in cui sfidare sistematicamente l’appropriazione e l’abuso
di potere e assicurare meccanismi di educazione reciproca e un cambio di
prospettiva.
Sostanzialmente, solidarietà significa avere empatia e rispetto per le
lotte degli altri, considerare se stessi come combattenti dalla stessa
parte quando ci si impegna in un processo di auto-liberazione reciproca,
senza ignorare i differenti punti di partenza, le esperienze, i
contesti e le identità. La migliore gratificazione di una solidarietà
genuina è che tutti i soggetti coinvolti imparino gli uni dagli altri
come organizzarsi. Pertanto, in conclusione, come sottolineano le
persone provenienti da posti come il Chiapas o il Kurdistan, solidarietà
vuol dire “andare a fare una rivoluzione nel proprio posto!”.
Una politica di identità senza internazionalismo rimarrà sempre
limitata, in quanto non può portare a una ampia emancipazione in un
sistema globale di oppressione e violenza, così come l’internazionalismo
senza il rispetto per le lotte radicate localmente rimarrà superficiale
e fallimentare, in quanto incapace di riconoscere la profonda
complessità delle diverse frequenze delle grida per la libertà.
Farmi le spalle larghe, rafforzerà anche voi – e questa è la sola
formazione nella quale possiamo combattere contro quest’ordine mondiale
sessista, razzista, imperialista, capitalista e assassino.